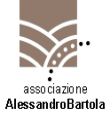Tu sei qui
Diversificazione o specializzazione?
Università Politecnica delle Marche
Agrimarcheuropa, n. 5, Dicembre, 2014

Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura sono concetti spesso interscambiati nel linguaggio comune. In realtà, a voler essere più precisi, il primo dovrebbe esprimere una serie di potenziali attività che l’agricoltura è in grado di svolgere, mentre il secondo indicherebbe lo svolgimento di una o più attività più o meno connesse all’attività agricola principale, ovvero la messa in pratica delle svariate potenzialità che il mondo agricolo potrebbe offrire.
Al di là delle possibili elucubrazioni sull’utilizzo dei due termini concettuali, fatto sta che la diversificazione in agricoltura (o la multifunzionalità fatta in concreto) può rappresentare un utile integrazione ad un reddito agricolo sempre più eroso dalle fauci della grande distribuzione organizzata o una strategia consapevole per ampliare ulteriormente il proprio fatturato, a tal punto da divenire l’attività principale.
Più volte si è sentito dire che la diversificazione è una modalità di fare impresa alla quale ricorrono soprattutto le piccole aziende per integrare il proprio reddito, oltre ad essere una strada obbligata e sempre più percorsa da quanti desiderano continuare a fare il mestiere di agricoltore. Le evidenze statistiche sembrano però confutare questi luoghi comuni. I dati, da considerare però con le dovute cautele specie in relazione alle modalità di rilevazione soggette a significativi cambiamenti, mostrano infatti una tendenza al ridimensionamento del fenomeno, una dimensione non affatto piccola delle imprese che diversificano e una certa specializzazione nelle attività di diversificazione.
Su questo pesano indubbiamente importanti cambiamenti strutturali che hanno interessato l’agricoltura in questi decenni, come l’espulsione delle imprese marginali e il rafforzamento di quelle più efficienti in grado di competere sui mercati. Ma può dipendere anche da altri fattori. Uno di questi è legato al capitale sia umano che finanziario. Per svolgere altre attività, che non siano solo quelle prettamente agricole, occorrono anzitutto conoscenze specialistiche, non tanto quelle acquisite sui banchi di scuola spesso solo teoriche e insufficienti per affrontare la realtà dei mercati, bensì quelle conquistate sul campo. Per assimilare queste conoscenze, bisogna inevitabilmente specializzarsi. Non è possibile pensare di fare mille cose alla volta, per farle poi male tutte. Il mercato non perdona. C’è poi la questione finanziaria. Per diversificare, occorrono risorse e in un periodo come questo dove il credito boccheggia è arduo pensare di intraprendere nuovi percorsi di multifunzionalità, a meno di non possedere già una dotazione in grado di affrontare nuovi oneri. Ma anche gli indirizzi di politica fanno la loro parte. Dove la politica decide di investire, quindi di “specializzarsi”, gli agricoltori, in particolare quelli più freschi e intraprendenti, inevitabilmente si tufferanno. Ecco quindi il boom degli agriturismi degli ultimi decenni, spesso “specializzati” nel solo vitto e alloggio al pari di una pensione o un albergo ma con più incentivi, o del fotovoltaico degli anni più recenti, con le conseguenze paesaggistiche che noi tutti conosciamo. La moda del momento sembra invece quella dei birrifici agricoli, grazie al riconoscimento legislativo della birra come prodotto agricolo e alle risorse del PSR, alla quale forse se ne potrebbe affiancare presto un’altra, ovvero gli agrinidi e l’agro-sociale in generale, sospinti da una legge nazionale ad hoc, in verità ancora in discussione, che potrebbe mettere le ali all’agricoltura sociale. Ma non si può pensare che la spinta allo sviluppo delle aree rurali possa provenire per esempio dalla birra o da qualche altra pensata simile. Si vedono già scaffali della GDO stracolmi di birre agricole e artigianali, dai nomi e dalle etichette più fantasiose e dai prezzi non così tanto accessibili. Né si può pensare che l’agricoltura sociale, nonostante il suo importante contributo (e per questo meritevole di supporto) ma proprio per la sua complessità e la predisposizione che richiede oltre che per le possibili barriere di diffidenza che vanno infrante, possa rappresentare un modello di sviluppo diffuso. Altre potrebbero essere le vie. Una di queste è sotto gli occhi di tutti e aspetta solo di essere percorsa. E’ quella della foresta, orfana di adeguate iniziative politico-istituzionali. Con una scarsissima utilizzazione degli incrementi annui, ben al di sotto della media europea, l’Italia, e le Marche non fanno eccezione, rappresenta uno dei più grandi importatori di legname per i più svariati utilizzi. Eppure la superficie forestale continua a crescere e cresce nelle aree marginali, dove urgono interventi di valorizzazione e ripopolamento. I benefici derivanti dalla gestione e dalla manutenzione delle foreste in quei luoghi sarebbero consistenti, da quelli occupazionali e reddituali a quelli paesaggistici e ambientali. Per far questo occorre anzitutto una volontà politica. Ma in un paese, dove anche a causa di servizi informativi diseducativi, un bosco intricato e invaso da sterpaglie è assurto a simbolo di biodiversità, strategie che diano il via libera al taglio dei boschi anche se programmato e fatto con criterio potrebbero non incontrare il favore dell'opinione pubblica.
La diversificazione non è però solo una strategia economica dell’agricoltore, a volte dettata dagli opportunismi e dalle tendenze del momento, è anche una strategia ambientale. Coincide infatti con la scelta che l’UE, al termine di un percorso tortuoso iniziato nel 2011, ha adottato per tutelare la biodiversità per il tramite dei pagamenti diretti. Con la riforma della PAC 2014-2020, una componente dei pagamenti diretti è stata vincolata al rispetto di talune pratiche agricole definite benefiche per il clima e l’ambiente, che si aggiungono ai requisiti dell’eco-condizionalità. Attraverso di essa, l’UE ha tentato di salvaguardare i pagamenti diretti dalle numerose critiche ad essi rivolte che li vorrebbero cancellati o assecondati agli obiettivi della politica di sviluppo rurale, attribuendogli delle funzioni più comprensibili e diverse da quelle per cui sono stati a lungo conservati, ovvero premiare lo status di agricoltore e difendere con i denti i diritti acquisiti. Tutto questo sarebbe lodevole se non si entrasse nel merito delle decisioni, perché a ben vedere, leggendo i nuovi regolamenti, che sembrano uscire dalla penna dell’Azzecca-garbugli, l’esperimento non sembra affatto riuscito. Tra le diverse pratiche, spunta, oltre alla creazione delle aree di interesse ecologico e al mantenimento dei prati permanenti, sulle quali ci sarebbe molto da dire, anche la diversificazione delle colture. Per la prima volta, l’UE impone agli agricoltori la pratica della diversificazione se vogliono continuare a ricevere aiuti nel primo pilastro. A dirla tutta, la diversificazione è la soluzione alla quale l’UE ha dovuto ripiegare in sostituzione della rotazione colturale. In altre parole, l’effetto ambientale che si voleva produrre doveva essere quello della rotazione, trascurando però un dettaglio non di poco conto. Chi assicura che l’agricoltore, nel rispetto comunque delle pratiche imposte, non mantenga le stesse colture per un numero di anni indefinito, vanificando quindi il risultato atteso in termini di biodiversità? E’ vero che non si parlerà più del problema della mono-coltura, ma solo perché ne avremmo altri, ossia quelli della bi-coltura o tri-coltura a seconda delle dimensioni aziendali. Non è neanche certo che il primo di problema sparisca. Infatti, volendo addolcire la pillola, l’UE ha deciso di esentare dall’obbligo tutti i piccoli agricoltori, con una superficie a seminativo inferiore ai 10 ettari. La conseguenza è che nelle agricolture frammentate, pensiamo all’Italia, un esercito di agricoltori potrà ricevere il pagamento verde senza fare niente. Va certamente riconosciuto che così facendo si tutelano quegli agricoltori e quelle agricolture che non possono permettersi di introdurre nuove pratiche e quindi sostenere maggiori costi, ma in tal modo si svilisce la natura stessa del pagamento verde. Se l’intenzione era quella di tutelare i più piccoli e preservare il territorio, perché non rafforzare il sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale invece di prevedere esenzioni nel primo pilastro? I problemi però non finiscono qui. Si pensi al modo in cui il pagamento verde può essere calcolato. Nel suo tentativo quasi riuscito di disintegrare l’unitarietà della politica agricola comune, trasferendo ampi poteri decisionali agli Stati membri e minando per questo il principio del mercato unico, l’UE ha concesso a quanti hanno optato per la convergenza graduale la possibilità di calcolare i pagamenti verdi in funzione dei titoli posseduti, il cui valore iniziale è derivato a partire da quello storico. La conseguenza paradossale è che due agricoltori che diversificano allo stesso modo e adottano le altre pratiche in eguale numero e intensità, e che per questo dovrebbero produrre gli stessi benefici ambientali (sempre che ve ne siano), riceveranno un pagamento diverso se hanno titoli di valore diverso. Purtroppo questa è stata la scelta dell’Italia, una scelta probabilmente attesa, ma comunque, a sua giustificazione, indotta dalle decisioni poco felici assunte ad un livello istituzionale ben più alto, il quale avrebbe dovuto svolgere una funzione correttiva anziché alimentare eventuali e possibili anomalie a livello di singolo paese.